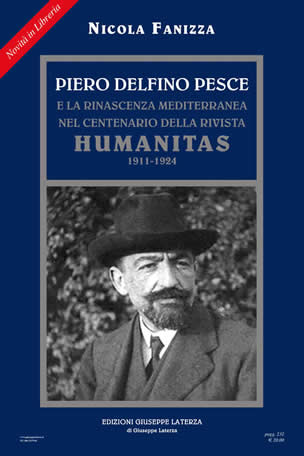La vita spezzata
Nel primo lustro del Novecento gli interessi di Pesce continuano ad essere precipuamente artistici. Nel 1901, scrive alcune novelle che vengono pubblicate in volume col titolo di Macchiette; nel 1902, inizia la sua collaborazione con la rivista «La Nuova Parola», con contributi di carattere prevalentemente critico-letterario; sempre nello stesso anno pubblica, presso l’editore Vecchi di Trani – una città che dista circa trenta chilometri dal capoluogo pugliese –, una raccolta di liriche intitolata Preludio; e, infine, nel 1904, porta a compimento la sua riflessione sull’arte, pubblicando, per la casa editrice Laterza di Bari, Riflessi,che si presenta come il suo libro più importante.
Per quel che riguarda le «novelline» – è questo il sottotitolo del suo primo libro –, il lettore si trova di fronte a vicende che rimandano per lo più alla vita dell’autore: su sei racconti, quattro sono ambientati a Napoli; gli altri due, in luoghi indeterminati.
Il teatro San Carlo di Napoli fa da sfondo all’esile trama della prima novella, Il mezzano. Qui Arturo, il protagonista, «avvia per spasso i matrimoni degli amici e delle amiche, ha sulle dita tutti i disponibili e le disponibili di sua conoscenza, propone, consiglia, incita; e nei lacci altrui trova la soddisfazione orgogliosa dello scapolo impenitente, che si ritiene torre tetragona, salda contro le seduzioni femminili».
Arturo era un campione del «dover essere»: aveva, infatti, una straordinaria capacità nell’adeguare il suo comportamento alle aspettative della società. Si rendeva, però, conto della sua incompiutezza – nessun uomo è un’isola! – solo quando l’altra irrompeva nella sua vita con la sua dirompente carica erotica: «Il cuore aveva ogni volta un tuffo, i nervi una contrazione improvvisa; ma la povera mollicina dell’amore, chiamata a scrivere le parole nuove nel libro della vita, era spezzata, ed i frammenti ferivano, aguzzi ancora, come allora, come sempre». L’«amore del mestiere portato al delirio, alla follia» gli impediva comunque di dire sì alla vita.
Il tema del conflitto fra l’istituente, come gioco che produce il nuovo, e l’istituito, come rito che comporta la ripetizione, è presente pure nella novella Falsario!, in cui si parla di Antonino, uno studente orfano di padre, «nato in un paesello della Basilicata montuosa». Ciò che qui apporta detrimento alla vita di Antonino, che si era trasferito a Napoli per frequentare l’università, è l’educazione rigorista che gli era stata impartita dai genitori, dai preti e dagli insegnanti. Spinto dal suo rigorismo morale – in osservanza della «religione del puro dovere» –, lo studente lucano aveva prestato una parte cospicua del mensile a un suo compaesano, rimanendo ben presto senza soldi. Da qui i morsi della fame lo incitano a sopravvivere anche a costo di commettere un reato: lo studente utilizza, infatti, un biglietto falso, che gli era stato rifilato, per comprarsi da mangiare. E tuttavia la pressione esercitata dai fantasmi della spelonca (educazione) gli fa venire le vertigini: «Un sudore ghiacciato gli coprì le membra, mentre il corpo veniva meno in una sensazione di smarrimento e di vuoto. Tentennò alquanto e, quasi senza polso, cadde su di una sedia, accanto al tavolino, innanzi alla cena intatta. Più del digiuno poteva il rimorso, povero figliolo!».
Quando si perseguono fini morali senza tener nel debito conto le reali condizioni di esistenza – cioè i bisogni, i desideri e le passioni –, si corre il rischio di creare un mondo di pura astrazione. Un mondo in cui non c’è spazio per la vita: «Gli allori del puro volere – scriveva Hegel – sono foglie secche che non sono mai state verdi!».
Tuttavia quando Pesce parla di questo ragazzo, probabilmente sta parlando di se stesso: lo studente lucano, allo stesso modo di Pesce, ha avuto un’educazione chiesastica ed è rimasto orfano. Proprio perché non riesce a modificare alcuni aspetti della sua personalità, Pesce li trasferisce sul piano fantasmatico – là dove può vincere! – nella prospettiva di prenderne le distanze. Di fatto Pesce è un puro, un uomo che non accetta compromessi. Basti pensare a ciò che scrive in una lettera inviata al suo amico torinese Terenzio Grandi: sono stato «esonerato dall’insegnamento all’Istituto Tecnico per non essere intervenuto alla commemorazione della Marcia su Roma».
Spesso sono i fantasmi che signoreggiano nei sotterranei del nostro immaginario a impedirci di scrivere nuove parole nel libro della nostra vita. Nondimeno quegli stessi fantasmi, altre volte, ci spingono a spezzare la penna agli altri. È questo il tema della novella La donna di cuore, in cui Pesce ci racconta una storia in cui si allude a un amore ancillare di tipo saffico con inflessioni sadiche. Protagonista è Gertrude, un’anziana signora che era conosciuta per la sua liberalità, anche se la sua generosità «aveva qualche cosa di spettacoloso e di ostentato che stringeva il cuore e faceva male».
Donna Gertrude aveva accolto nella sua casa un’orfanella di nome Silvia, «cui non dava stipendio, perché avevala più in conto di figliola che di serva»9. Poteva dire di averla cresciuta lei. Silvia era ormai giovane e bella e godeva delle attenzioni morbose della padrona: «La sera, manco a dirlo,‘Silvia mia, Silvia della padrona’ la confondeva di premure e di tenerezze, che la povera fanciulla attribuiva a mali nervosi di cui la padrona era afflitta, mali a cui attribuiva anche altri trattamenti, assai meno teneri, ma che, per sua sciagura, si ripetevano molto spesso».
Donna Gertrude nel corso degli anni precedenti aveva messo da parte delle provviste di denaro per la fanciulla nella prospettiva – così diceva – di farla maritare. Ma nel momento in cui si apre per Silvia la possibilità di un matrimonio, la padrona cambia idea. Ripensando ai servizi che la servetta svolgeva, al fatto che le gambe cominciavano a pesarle e, perché no, anche a quegli «altri trattamenti» inconfessabili, «disse ad alta voce ciò che pensava da tanto tempo: – Questo matrimonio non si farà, né presto, né mai! –».
L’importanza di questo libro va individuata nel fatto che qui viene veicolato per la prima volta il conflitto istituente-istituito, che si configura come il nucleo generatore della sua futura riflessione.
D’altronde, quanto più Pesce stigmatizza le situazioni di vita spezzata tanto più ci spinge ad amare la vita. L’arte, infatti, deve servire per liberare i sotterranei del nostro immaginario dai fantasmi che ci vogliono inchiodare nella zona dell’essere sempre identico; per promuovere inediti percorsi di conoscenza; per render meno opaco questo mondo; per mettere in atto nuove pratiche di liberazione; e, infine, per andare oltre!